




Le considerazioni circolate nei media sui risultati dei referendum dell’8-9 giugno si distinguono nettamente da quelle relative ai precedenti sulla giustizia. Mentre nel giugno 2022 calò un assordante silenzio sul significato politico del loro esito per evidenziare soltanto il mancato raggiungimento del quorum, stavolta si è insistentemente riflettuto sulle conseguenze insite nella distribuzione dei voti espressi, oltre che sui modi per scongiurare la celebrazione a vuoto del voto referendario.
L’impressione è che i commenti seguiti al fallimento dei referendum voluti dalla Cgil di Maurizio Landini, col sostegno di gran parte delle forze di opposizione dell’attuale maggioranza di governo, abbiano in sostanza riproposto lo stesso approccio mistificatorio che era stato all’origine della loro promozione. Così come la chiamata alle urne era avvenuta non tanto per intervenire sull’oggetto dei referendum, ma per mobilitare l’opposizione e riunirla sotto una determinata guida, altrettanto è avvenuto per quanto riguarda le interpretazioni fornite all’indomani del voto tutte all’insegna dell’opportunismo di parte.
Il problema è che su tutti gli argomenti collegati a queste interpretazioni – dalla spiegazione dell’elevato astensionismo agli interventi immaginati per contrastarlo e finanche sugli stessi numeri finali dello spoglio dei voti, dai quali gli sconfitti pretendevano di trovare comunque ragioni di soddisfazione – non si è fatto altro che seguire false piste.
Una prima deviazione interpretativa ha riguardato proprio il non voto, che è stato presentato da un lato come la manifestazione di un ridotto senso civico o di qualunquismo e, dall’altro lato, come una forma di dichiarata adesione a chi – la maggioranza di governo – si opponeva alla consultazione referendaria. Come già osservato altrove, il mancato raggiungimento del quorum si è ripetuto costantemente da dieci anni a questa parte e ciò si spiega nella raggiunta consapevolezza di un’ampia quota del corpo elettorale circa la vanità degli esiti referendari, visto che anche molti di quelli vinti in passato dai promotori sono stati poi disattesi nel concreto.
Né la conquista del quorum dipende dal tipo di quesito sottoposto al voto o dalla sua immediata comprensibilità, come sostenuto da Tito Boeri («la Repubblica», 10 giugno): referendum su problemi etici generali, come quelli della procreazione assistita, hanno avuto partecipazioni ridotte; mentre quesiti tecnici e alquanto ostici, come quelli sull’acqua pubblica, il quorum lo hanno ottenuto. Lo avevamo rilevato già in occasione dei cinque referendum sulla giustizia: a fare la differenza tra un referendum ad alta partecipazione e quello privo di quorum, è soprattutto la valenza emotiva di cui viene caricato il confronto democratico che l’accompagna, perché la democrazia è prima di tutto una battaglia di idee, visioni del mondo e prospettive sul futuro.
I referendum dell’8-9 giugno questa carica non l’avevano, in quanto concepiti dai promotori – Maurizio Landini in testa – al solo scopo di effettuare un mega-sondaggio all’interno dello schieramento di opposizione al governo di Centrodestra, per stabilire quali equilibri di potere devono avere le sue varie componenti.

In questo senso, l’elevato astensionismo (comune anche al voto politico, basti pensare alle scorse elezioni europee disertate da oltre la metà del corpo elettorale) è solo l’indice della profonda crisi democratica che il nostro Paese vive da quasi trent’anni. Anziché preoccuparsi di recuperare consensi in quest’area, la classe politica nel suo insieme – a sinistra come a destra – persiste nell’operare in senso contrario e l’inaridimento della democrazia diretta referendaria, provocata dall’uso strumentale che ne hanno fatto i partiti, è parte non secondaria di questo operato antitetico alla ri-vitalizzazione di una democrazia partecipata.
Per questo, anche le recriminazioni circa la presenza del quorum, oppure – sul versante opposto – la richiesta di scoraggiare l’indizione di referendum aumentando il numero di firme necessarie, ci appaiono fuorvianti e rendono manifesta l’ipocrisia di fondo che ispira entrambi gli schieramenti oggi in competizione. Il sostanziale blocco dell’opzione referendaria non dipende certo dalle norme che lo regolano, ma dal sabotaggio che il sistema politico e istituzionale (attraverso le determinazioni della Consulta) le hanno inferto.
Ogni modifica del dettato costituzionale al riguardo produrrebbe più problemi che altro, visto che l’abbassamento del quorum oggi ventilato da taluni potrebbe consegnarci esiti per cui una esigua minoranza di votanti (come del resto già ora accade in caso di superamento della metà più uno degli elettori, laddove poco più di un quarto loro può abrogare le leggi approvate in Parlamento) prevarrebbe sulle determinazioni di una rappresentanza parlamentare ampiamente depotenziata, in specie dopo l’improvvida e inutile riduzione dei seggi introdotta dalla riforma voluta dal Movimento 5 Stelle nel 2020.
Come pure paradossale risulta la lamentazione, affiorata tra i promotori alla chiusura dei seggi, relativa alla campagna pro-astensione o alla scarsa informazione che avrebbe preceduto il voto referendario. Che ad avanzare queste lagnanze siano le stesse forze politiche (PD in primo luogo) che tre anni fa, nei referendum sulla giustizia, fecero di tutto prima per oscurarli e poi farli fallire, è una palese dimostrazione del fariseismo che le caratterizza.
Altrettanto lontano dal vero è evocare una distrazione dei media sui temi referendari, che anzi hanno avuto un’ampia eco mediatica grazie al pronunciamento favorevole di molti personaggi noti al grande pubblico: stavolta non abbiamo avuto una Luciana Littizzetto che, da un programma tv di prima serata, invitasse a disertare le urne come accaduto per i referendum sulla giustizia, i quali fra l’altro si svolsero in una sola giornata (domenica 12 giugno 2022) invece che in due giorni come successo quest’anno domenica 8 e lunedì 9 giugno.
Il giorno in più è servito forse ad aggiungere un 10% di votanti (fermatisi comunque sotto il 30%), ma non ha scongiurato il fallimento dell’iniziativa referendaria animata dalle forze politiche del cosiddetto Campo largo (PD, sinistra e 5Stelle). Piuttosto che prenderne atto, molti loro esponenti hanno vagheggiato, tanto alla vigilia che dopo il voto, un presunto successo riconoscibile nel numero dei partecipanti.

La narrazione che vuole trovare segni di riscossa in una sconfitta dà il segno dello stato di confusione presente in “questa” sinistra: un referendum ha successo se ottiene il quorum e questo non l’ha ottenuto. Quanto alla lettura politica che se ne vuole dare, è di tutta evidenza che anche a voler considerare un proprio patrimonio di consenso i 13 milioni di Sì del quesito più votato (quello sul jobs act), essi sono inferiori alla somma dei voti ottenuti tre anni fa dall’insieme delle forze dai 5Stelle a Calenda, che il 25 settembre 2022 capitalizzavano 14 milioni di preferenze (due milioni in più del Centrodestra).
Immaginare che il risultato dell’8-9 giugno rappresenti la potenziale piattaforma di rilancio per il Centrosinistra significa semplicemente ignorare la questione di fondo – questa sì davvero politica – del momento: l’incapacità delle opposizioni odierne di rappresentare un’alternativa di governo, capace di esprimere un’azione coerente nel segno di un intento riformatore e non contando solo sull’assemblaggio di forze tenute insieme da un’impostazione prevalentemente ideologizzata, staccata dai dati reali.
Tanto più se si considera la percentuale di No (36%) registrata per il quinto quesito sulla riduzione dei tempi per la cittadinanza degli stranieri: un dato assai significativo, proprio per il fatto che scaturisce per lo più entro una platea a prevalenza di centrosinistra e che segnala un dissenso da una politica immigrazionista lontana dalla realtà e dalle domande presenti nella società (sia degli italiani che degli stranieri, poco propensi a rinunciare alla propria cittadinanza per acquisire quella italiana).
Aver ignorato la necessità di proporre un indirizzo diverso su questo tema, che fosse in grado di governare razionalmente il fenomeno migratorio, conferma il distacco dalla realtà di tanti esponenti – sia cattolici che ex-post Pci – della sinistra italiana e che, di fatto, la isola pure dal resto della sinistra europea (dai socialdemocratici danesi ai laburisti e finanche i socialisti spagnoli) dove è da tempo in atto l’adozione di politiche più pragmatiche, volte a porre rimedio a scelte tanto astratte quanto controproducenti per tutti, a cominciare dai migranti medesimi.
Dal voto dei referendum ci sarebbe dunque molto da apprendere, se il dibattito pubblico del circuito informativo riuscisse a svincolarsi da un settarismo senza costrutto, fornendo elementi che rafforzino le ragioni della partecipazione consapevole.


|
é uscito il N° 119 di Quaderni Radicali "EUROPA punto e a capo" Anno 47° Speciale Maggio 2024 |
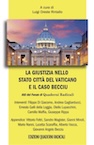
|
è uscito il libro Edizioni Quaderni Radicali ‘La giustizia nello Stato Città del Vaticano e il caso Becciu - Atti del Forum di Quaderni Radicali’ |

|
è uscito il libro di Giuseppe Rippa con Luigi O. Rintallo "Napoli dove vai" |

|
è uscito il nuovo libro di Giuseppe Rippa con Luigi O. Rintallo "l'altro Radicale disponibile |