

Sabato 3 maggio (venne Mario Martone a parlarne) e oggi sabato 31 maggio (Alfonso Amendola, Alfonso Conte, Pina De Luca, Emilio Giordano e Francesco Mancuso) il Comune di Sant'Arsenio, il paese in cui sono nato - nel fascinoso Vallo di Diano, nella Campania meridionale tra Cilento e Lucania - dedica due giorni alla mia poesia. Nella Braida, la grande piazza, sarà oggi pomeriggio piantato un albero per ricordare queste ore lucenti: leggerò questi 125 versi appena scritti.
Il titolo è La casa sul torrente: la strada in cui sono nato la notte del 4 febbraio 1938 era, allora, un torrente dal letto di pietra.

RINO MELE
La casa sul torrente
Sempre, il paese è un’astrazione,
edificio infero
di cui vedi le stanze alte coi balconi,
l’astrico, i tetti, i lacunari
del cielo,
l’alba delle finestredde, gli specchi
che escono dal sonno:
negl’infiniti sotterranei, corridoi interrati,
l’enigma di rustici ipogei,
le madri scendevano a nascondere
le lacrime.
A Sant'Arsenio, d’inverno, le piogge
diventavano lago
e sul fango della mia torrenziale concava
strada
i cavalli lasciavano i segni delle ruote
nel sussultare a precipizio
delle acque, quel perpetuo scivolare
sulle pietre:
il piccolo Acheronte che chiedevamo
di attraversare quando le onde
s’alzavano tra le case incastrate nel
dirupo della via,
dove perdevamo l’anima a correre.
La mia casa è ancora lì sul torrente
del Lavinaio, la strada dove sono nato
al numero 17: ne sento la voce
muta nei canti delle bambine in cerchio,
a rincorrersi,
in un instancabile confronto: “Vieni vieni
gioia / nu mazzo re viola /
nu mazzo re petrosino / vieni
vieni gioia mia”. Le piogge non finivano.
Ma all’improvviso il fango
si prosciugava e io correvo al confine
dell’orto,
verso un contorto salice
selvatico su cui salivo e, nell’incavo
dei rami restavo per ore:
lì ho vissuto in anticipo la mia vita,
e non sarei dovuto scenderne mai più.
Al centro, tra le case verso
la montagna e le casedde nella pianura,
l’immensa Braida,
i morti camminavano tra i vivi,
e non morivano mai: poi apparivano,
figure di silenzio, all'Ossario,
teste e tibie, femori feriti
e, sovrapposti, altri crani con orbite
aperte su smemorate visioni.
Al mio paese il sonno
era come una fune: ci s’aggrappava
nel buio delle scale. “Nu capo re suonno”
supplicava, negli scrosci interminabili
di pioggia,
la voce chiusa nel dolore: sentiva
il torrente del Lavinaio diruparsi,
portare con sé tronchi
e rami fino a liberarsene
contro la parete del Limitone, il lungo sedile
di pietra contro cui la strada d’acqua
infrangeva
la sua nuda tenebra.
Dopo l’ultima guerra, il paese è cambiato,
è diventato periferia
d’una inesistente città sempre lontana:
prima, era la visione capovolta
delle sue case.
Le notti di guerra erano atroci: mia madre
roteava piano
un tizzone se camminavamo nella tenebra,
in quel luccichio stellato vedevamo la notte,
ci muovevamo nelle erbe
bagnate
dei sentieri dell’orto.
Fino a metà del secolo scorso,
a Sant’Arsenio
era come se il paese contenesse un altro
paese, più leggero:
se qualcuno
stava per morire, il paese ne era avvertito:
suonava la campana dell’Agonia,
un suono veloce,
metallico: in quegli istanti per chi
aveva messo il piede sul limite delle cose,
la campana suonava in fretta:
diceva - a lui morente - che moriva:
lui sapeva
di stare per salire un sentiero di terra
nel quale precipitare: risaliva
a stento prima di sotterrarvisi dentro.
Passava di corsa un sacerdote chiuso
in uno stretto manto, un piviale,
bianco e oro
a nascondere la pisside con l’ostia, l’olio
santo. I ragazzi si fermavano,
smettevano di correre.
La guerra non finiva mai, in piazza
un piccolo teatro mostrava a tutti
quello che nessuno era:
gli attori gridavano un finto
dolore, si gettavano sulle tavole
del palco, ne risorgevano tra gli applausi.
La vita del paese
era un continuo scavare solchi,
gettarci la semenza, coprirli con la terra
del colmo, maturando l’attesa.
L'alta chiesa del Settecento
era fredda, cento anni fa i preti
ancora andavano a caccia vestiti di verde,
sparavano agli uccelli
nel predicare il vangelo. Al centro,
la Braida immensa
era una foresta di platani,
potevi viverci una vita, morirci e rinascere.
Di notte, l’acquata lavava tutto,
nei campi
si specchiava la luna,
si nascondeva nei canali, cantava
nella voce delle madri. All’alba
i contadini già lavoravano,
pensavano ai volto di gesso dei padroni
addormentati, senz'anima e,
vangando
il nero corpo tenace della terra, ridevano.
_________________________________
Rino Mele (Premio Viareggio Poesia 2016, terna finale con “Un grano di morfina per Freud", ed. Manni) scrive, il venerdì e il martedì, su “Agenzia Radicale”. Dal 2009 dirige la Fondazione di Poesia e Storia. Il nome della rubrica è “Poesì”, come nel primo canto del “Purgatorio” Dante chiama la poesia.
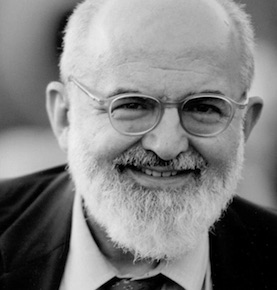
Leggi l'intera sequenza di POESÌ